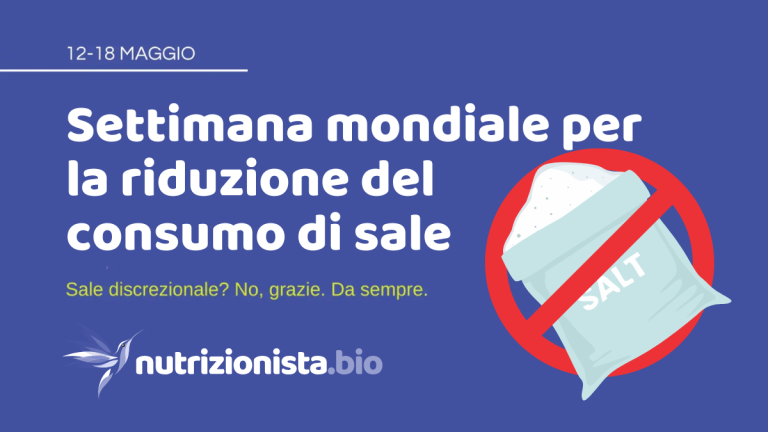Introduzione – Le proteine oltre la moda: serve chiarezza
Negli ultimi anni, il dibattito attorno alle proteine è diventato sempre più acceso, trasformandosi talvolta in una vera e propria tendenza alimentare. Tra video sui social, piani alimentari scaricabili gratuitamente, app che calcolano macros e influencer che dispensano consigli, si è creato un vortice di confusione che spesso allontana dalla realtà biologica. Ecco perché oggi, più che mai, è necessario fare chiarezza su cosa sono le proteine, a cosa servono, e soprattutto quante proteine assumere al giorno.
Molte persone, infatti, tendono a estremizzare il consumo proteico, mentre altre lo sottovalutano completamente, affidandosi a piani standardizzati che non considerano lo stato fisiologico individuale, né il contesto specifico di ogni persona. Questo approccio “copia-incolla” rischia di compromettere il corretto funzionamento dei processi metabolici, che richiedono invece un equilibrio costruito su misura, basato su parametri reali e individuali.
Un piano nutrizionale ben costruito da un Biologo Nutrizionista, infatti, non si limita a indicare “tot grammi di proteine”, ma si fonda sulla valutazione complessiva dello stato di salute della persona, del suo stile di vita, della risposta dell’organismo nel tempo e delle eventuali esigenze fisiologiche specifiche (es. gravidanza, allattamento, attività sportiva).
In questo articolo vedremo:
- Cosa sono le proteine e a cosa servono
- Qual è il fabbisogno proteico reale secondo la letteratura scientifica aggiornata
- Come calcolare quante proteine assumere al giorno, evitando generalizzazioni pericolose
L’obiettivo è offrire una guida chiara, fondata su basi scientifiche verificate e utile per chi desidera comprendere davvero il ruolo delle proteine nel contesto della propria alimentazione quotidiana.
Cosa sono le proteine e perché sono fondamentali
Per comprendere davvero a cosa servono le proteine, è necessario partire da una base solida, ma chiara, di biochimica. Le proteine sono macromolecole complesse, costituite da catene di amminoacidi unite tra loro da legami peptidici. Ogni proteina ha una struttura tridimensionale precisa, che ne determina la funzione biologica. Il nostro organismo utilizza circa venti amminoacidi principali, otto dei quali sono essenziali: il corpo umano non è in grado di sintetizzarli autonomamente e quindi devono essere introdotti attraverso l’alimentazione.
Più di un “nutriente”: una presenza funzionale
Ridurre le proteine a semplici “mattoni per i muscoli” è una semplificazione fuorviante. In realtà, queste molecole svolgono ruoli strutturali, regolatori, enzimatici, immunitari e ormonali. Sono coinvolte nella:
- Costruzione e riparazione dei tessuti (muscoli, pelle, organi)
- Sintesi degli enzimi, fondamentali per catalizzare tutte le reazioni biochimiche nel corpo
- Produzione ormonale, come nel caso dell’insulina o del glucagone
- Difesa immunitaria, grazie alla produzione di anticorpi
- Regolazione del pH e del bilancio idrico
- Trasporto di molecole, come fa l’emoglobina con l’ossigeno nel sangue
Ogni funzione svolta da una proteina è il risultato di una sequenza specifica di amminoacidi, che ne determina la forma e la funzione. Questo rende fondamentale non solo la quantità, ma soprattutto la qualità delle proteine assunte.
L’importanza della qualità
Non tutte le proteine sono uguali. La composizione aminoacidica e la biodisponibilità sono due fattori chiave per valutarne l’efficacia nel sostenere i processi fisiologici. Alcune fonti sono più complete, altre meno; ma la vera discriminante è la qualità della materia prima e la capacità del corpo di utilizzare in modo efficiente i nutrienti contenuti.
Per questo motivo, un piano nutrizionale efficace non si limita a indicare “tot grammi” da raggiungere, ma prevede una valutazione professionale, personalizzata, che tenga conto di:
- Stato fisiologico attuale
- Obiettivi della persona
- Risposta metabolica individuale
- Qualità e compatibilità delle fonti alimentari scelte
Non esiste un “alimento migliore in assoluto”: ciò che è adatto per un individuo, potrebbe non esserlo per un altro. È qui che si inserisce il ruolo chiave del Biologo Nutrizionista, che sa costruire un piano su misura, dinamico e adattabile nel tempo.
Il legame tra proteine ed equilibrio glicemico
Un altro aspetto cruciale è il contributo delle proteine alla regolazione della glicemia. Inserite con logica all’interno dei pasti, le proteine aiutano a modulare la risposta insulinica, contribuendo a ridurre o evitare picchi glicemici. Questo ha un impatto diretto su numerosi fronti:
- Controllo del peso corporeo in percorsi di rimodulazione della composizione corporea
- Prevenzione di meccanismi infiammatori cronici, legati a sbalzi glicemici ripetuti
- Supporto all’energia stabile, evitando fasi di ipoglicemia reattiva
Quando la distribuzione proteica è calibrata, il pasto ha un effetto più “controllato” sul metabolismo, stimolando in modo più efficace i processi di utilizzo dei nutrienti e riducendo la necessità di compensi eccessivi a livello endocrino.
Fabbisogno proteico: in realtà è molto più alto di quanto si pensi
Uno degli errori più comuni che si commette quando si parla di quante proteine assumere è quello di riferirsi a numeri “di riferimento” standard, spesso estrapolati fuori contesto.
Facciamo un po’ di chiarezza.
Un valido strumento di riferimento è rappresentato dalle tabelle LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti), redatte dalla SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), che forniscono indicazioni suddivise per età, sesso e stato fisiologico.

Come visibile nella tabella, sono indicati diversi valori rappresentativi.
In corrispondenza dell’AR, valore di assunzione raccomandata come fabbisogno medio, ritroviamo per l’adulto, una quantità di 0,71 grammi di proteine per kg di peso corporeo. Questo significa che è la quantità media di proteine necessaria per soddisfare il fabbisogno del 50% degli individui in buona salute in una specifica fascia di età/sesso, non è il valore da seguire per l’intera popolazione, perché lascia fuori metà delle persone.
Questo è un valore che ancora oggi, da molti, viene considerato come la quantità ideale da utilizzare e la si ritrova proposta in diversi articoli presenti sul web è considerata per l’elaborazione delle grammature degli apporti proteici da consigliare nelle diete. In realtà, questa è una soglia minima di sopravvivenza, non certo un valore ottimale per favorire la funzionalità fisiologica, soprattutto in soggetti attivi o con esigenze particolari. Degno di nota è che la quantità di 0,6 – 0,7 g / kg / die, è la quantità raccomandata a persone che hanno problematiche renali, valori che si possono consultare nelle linee guida della Società Italiana di Nefrologia (SIN), che in collaborazione con esperti del settore, ha delineato specifiche raccomandazioni riguardo l’apporto proteico per i pazienti affetti da malattia renale cronica (MRC) (in Ingelse: Chronic Kidney Disease – CKD). Queste indicazioni variano in base allo stadio della malattia e alla presenza di condizioni concomitanti.
Da questo già si può comprendere che non si può utilizzare lo stesso apporto per un soggetto sano.
In corrispondenza del PRI ossia l’assunzione raccomandata per la popolazione (Population reference intake: PRI), ovvero il riferimento per l’assunzione raccomandata per la popolazione, troviamo sempre per l’adulto, invece, il valore di 0,9 g di proteine per kg di peso corporeo. Questo è un riferimento per coprire quasi tutto il fabbisogno della popolazione (circa il 97,5%).
Attenzione però a ricordare che questo valore va contestualizzato con il soggetto che abbiamo di fronte, con la sua quotidianità, la sua attività giornaliera e molto altro. Infatti, il fabbisogno proteico giornaliero, è decisamente maggiore per esempio per i lattanti, i bambini, la donna in gravidanza e allattamento e, nell’anziano addirittura, è stato stabilito un valore di 1,1 g/kg di peso corporeo come obiettivo nutrizionale per la prevenzione.
Secondo una mole crescente di letteratura scientifica, il fabbisogno proteico giornaliero può salire fino a 1,6 g/kg di peso corporeo e oltre in determinati contesti (sportivi, persone in percorsi nutrizionali specifici ecc).
Spesso, nei piani nutrizionali formulati su indicazioni generiche, si sottostima la reale necessità proteica, con effetti a lungo termine sulla composizione corporea, sul recupero tissutale e sul controllo glicemico.
È per tale motivo che questi valori e tabelle vanno interpretati dal Biologo Nutrizionista con senso critico e sempre nel contesto della singola persona. Non si tratta di “numeri fissi” da seguire in automatico, ma di valori indicativi, utili per costruire una base da cui partire nella personalizzazione del piano nutrizionale.
Il calcolo del fabbisogno proteico richiede quindi una valutazione precisa del peso corporeo attuale (e non del peso ideale, e qui si potrebbe anche parlare della massa magra del soggetto!), del livello e tipo di attività fisica, della composizione corporea e dell’obiettivo nutrizionale. Solo così si può stabilire quante proteine assumere al giorno in modo efficace.
Concludendo, il concetto di quante proteine al giorno servano davvero non può essere affrontato in maniera semplicistica. Serve un approccio personalizzato, attento e consapevole, che valorizzi il ruolo delle proteine non come “super alimento” da rincorrere, ma come componente fondamentale da inserire con logica e criterio in un piano nutrizionale costruito su misura.
Carenza di proteine: conseguenze dannose reali e spesso sottovalutate
La carenza proteica non è una condizione rara solo nei Paesi in via di sviluppo: può manifestarsi anche in contesti occidentali, soprattutto in specifiche fasce della popolazione come anziani, soggetti con scarso apporto nutrizionale, persone con patologie croniche o stati infiammatori prolungati.
Nella nostra pratica quotidiana, riscontriamo purtroppo che la quasi totalità delle persone non soddisfa il loro fabbisogno proteico nelle loro abitudini quotidiane.
Secondo quanto riportato sia dalla SINU sia dalla Società Italiana di Nefrologia, un apporto inadeguato di proteine nel tempo può determinare alterazioni significative sul piano clinico e funzionale.
I principali effetti associati a un’insufficienza proteica includono:
- Riduzione della massa muscolare (sarcopenia), con conseguente perdita di forza e funzionalità, soprattutto negli anziani;
- Compromissione del sistema immunitario, con maggiore suscettibilità a infezioni;
- Difficoltà nella riparazione dei tessuti, importante sia nei processi di guarigione che nel mantenimento dell’integrità strutturale di pelle, unghie e capelli;
- Peggioramento dell’equilibrio glicemico, poiché una ridotta disponibilità di proteine può alterare la risposta metabolica post-prandiale;
- Edemi e ritenzione di liquidi, in casi più avanzati, per riduzione della pressione oncotica (fenomeno ben noto in nefrologia).
In ambito nefrologico, la Società Italiana di Nefrologia sottolinea che una carenza cronica di proteine può anche contribuire a un peggioramento dello stato nutrizionale nei pazienti affetti da malattia renale cronica (MRC), nei quali è già presente un bilancio delicato tra apporto proteico e funzionalità renale. Anche in questi casi, l’intervento del Biologo Nutrizionista è fondamentale per calibrare in modo preciso e sostenibile l’introduzione di proteine in funzione del quadro clinico.
Secondo la SINU, un apporto proteico costantemente sotto i livelli raccomandati può aggravare la perdita di massa magra, ostacolando la capacità dell’organismo di mantenere uno stato metabolico efficace e contribuendo a una condizione di fragilità progressiva.
Per questo motivo è essenziale evitare stime generiche e piani standardizzati: la quantità di proteine deve essere valutata con attenzione, sempre nel contesto metabolico, clinico e fisiologico della persona. La carenza, se trascurata, non è solo un parametro biochimico alterato: è una condizione che ha conseguenze reali sulla qualità della vita e sull’efficienza del corpo nel suo complesso.
Chi non assume abbastanza proteine oggi? Una carenza più diffusa di quanto sembri
Nel dibattito moderno sull’alimentazione si sente spesso parlare di “eccesso” di proteine, ma i dati e l’osservazione clinica raccontano tutt’altra storia: una grande parte della popolazione non raggiunge il proprio fabbisogno proteico reale. Si tratta di una carenza spesso silenziosa, che non si manifesta con sintomi immediati, ma che nel tempo può compromettere la qualità della vita e la funzionalità dell’organismo.
A rischio non ci sono solo le persone con restrizioni alimentari o patologie: gli anziani, le persone sedentarie, chi ha un’alimentazione irregolare o disordinata e chi è in sottopeso rappresentano alcune delle categorie che, più spesso, assumono quantità di proteine insufficienti rispetto alle reali necessità del corpo.
Anziani: il rischio della sarcopenia
Con l’avanzare dell’età, il corpo tende naturalmente a perdere massa muscolare. Nei contesti clinici e nutrizionali, si fa generalmente riferimento alla fascia di popolazione a partire dai 60 anni quando si parla di “anziani”, ma è importante considerare anche lo stato fisiologico reale della persona, e non solo l’età anagrafica.
Se questa perdita non viene contrastata con un adeguato apporto proteico e stimoli funzionali appropriati, si incorre in una condizione nota come sarcopenia, che non è solo un fatto estetico, ma coinvolge la capacità di movimento, l’autonomia e la salute metabolica complessiva.
Il paradosso? Molti anziani mangiano meno e peggio, trascurando proprio le proteine, che invece in questa fase della vita diventano ancora più importanti.
Secondo i LARN (IV Revisione, SINU 2014), per la popolazione con più di 60 anni viene indicato un valore di riferimento preventivo (SDT) di 1,1 g di proteine per kg di peso corporeo al giorno, superiore al PRI standard di 0,9 g/kg/die.
Questo dato riflette la necessità di un apporto proteico più alto non solo per coprire il fabbisogno medio, ma anche per prevenire la perdita di massa muscolare, supportare la funzionalità fisica e ridurre il rischio di disabilità.
Stile di vita sedentario e sottopeso: meno stimolo, meno attenzione
Chi conduce una vita sedentaria tende a mangiare meno per semplice riduzione dell’appetito, ma ciò comporta anche una minore assunzione di nutrienti importanti, tra cui proprio le proteine. Anche chi è sottopeso, pur avendo magari una dieta “quantitativamente sufficiente”, rischia di avere una scarsa qualità nutrizionale, con apporto proteico non adeguato alla ricostruzione dei tessuti o al supporto delle funzioni immunitarie.
Alimentazione disordinata: l'effetto "tutto e niente"
Chi mangia “a caso”, saltando pasti, improvvisando, affidandosi a cibo confezionato o “di corsa”, spesso cade in uno squilibrio in cui gli zuccheri e i grassi di bassa qualità predominano, mentre le proteine di buona qualità vengono trascurate.
Il punto chiave
Sottolineare che moltissime persone sono sotto il proprio fabbisogno proteico reale non vuol dire fare allarmismo. Significa invitare a guardare con occhi nuovi la propria alimentazione, chiedendosi non solo “sto mangiando abbastanza?”, ma anche “sto mangiando ciò che il mio corpo davvero richiede per funzionare al meglio?”. Un percorso fatto con un Biologo Nutrizionista permette di rispondere in modo serio e su misura, senza approssimazioni.
Contatta il tuo nutrizionista
Fonti di proteine: perché parlare di qualità prima ancora che di quantità
Quando si parla di proteine, il primo istinto è spesso quello di contare: “quante ne sto assumendo?”. Ma c’è un aspetto ancora più importante: la qualità delle fonti proteiche. Due alimenti possono contenere lo stesso numero di grammi di proteine, ma avere un impatto completamente diverso sull’organismo.
La differenza sostanziale tra le fonti proteiche non risiede nel numero, bensì in tre fattori centrali:
- Profilo amminoacidico e valore biologico
- Biodisponibilità
- Qualità della materia prima
Colesterolo e proteine: spesso la riduzione di uno porta al deficit dell’altro, attenzione al contesto individuale
Quando si hanno dei valori di colesterolo elevati, spesso, l’indicazione che si riceve è quella di ridurre fortemente molti alimenti con un contenuto elevato di colesterolo. Questi alimenti, prevalentemente di origine animale come uova, carne, molluschi, crostacei, affettati, latticini ecc. sono però anche tra le principali fonti proteiche.
L’errore più comune quando si cerca di adattare una dieta in autonomia per cercare di seguire queste limitazioni, è quello di sbilanciare la propria nutrizione a favore dei carboidrati, finendo per ridurre fortemente l’apporto proteico ed ottenendo un effetto opposto a quello desiderato sulla modulazione del colesterolo stesso.
Perchè? Se l’apporto dei carboidrati diventa sbilanciato nella dieta questo va ad impattare sulla produzione di un ormone, l’insulina, che è implicata nella cascata della produzione del colesterolo da parte del corpo stesso.
Di certo, l’assunzione di determinati alimenti, può influenzare i livelli ematici di colesterolo ma è bene sapere che questi sono in grado di impattare sui valori di colesterolo totale solo per un 20%. La restante quota, invece, deriva da quella che si chiama produzione endogena ovvero è il suo corpo stesso che produce questa sostanza perchè, anche se non spesso ricordato, è una sostanza importantissima per il corpo umano.
Infatti, è proprio l’insulina ad attivare la stimolazione di un enzima (l’HMG- CoA reduttasi), il quale a sua volta stimola la produzione di colesterolo. Tale enzima, inoltre, è attivato da ormoni tiroidei mentre è inibito sia da parte del glucagone (ormone antagonista dell’insulina) che dal colesterolo stesso. Ciò significa che se i livelli di colesterolo totale circolati sono elevati, questo inibisce la produzione endogena del colesterolo stesso.
Diventa importantissimo quindi seguire un’alimentazione che promuova il controllo della produzione di insulina per evitare che vi sia una eccessiva stimolazione, cosa che spesso invece succede quando si limitano molto gli alimenti contenenti elevati quantitativi di colesterolo… semplicemente perchè non si sa più cosa mangiare.
Inoltre, vanno valutati anche gli alimenti con contenuti di colesterolo elevati ed eventualmente ridotti bilanciando tutto il resto. Infatti, i livelli ematici di colesterolo sono il riflesso di molteplici situazioni e possono dipendere dal contesto metabolico della persona, dalla qualità degli alimenti che si portano in tavola, dalla composizione complessiva della propria dieta e dallo stato infiammatorio di base.
ll ruolo del Biologo Nutrizionista è quindi quello di orientare la persona verso delle scelte consapevoli, valorizzando la qualità delle fonti alimentari, suggerendo un adatto bilanciamento dei macro e micronutrienti con giuste associazioni nel pasto, indicando una precisa sequenza nell’ordine di consumo degli alimenti inseriti nello stesso pasto e durante la giornata.
Tutto va poi inserito in un quadro nutrizionale personalizzato ed adatto alla persona.
Proteine animali e vegetali: non solo una questione di etichetta
Le proteine animali, in genere, presentano un profilo amminoacidico completo: contengono tutti gli amminoacidi essenziali in proporzioni adeguate al fabbisogno umano. Sono quindi considerate ad alto valore biologico e hanno una buona biodisponibilità. Tuttavia, la qualità cambia enormemente in base alla provenienza della materia prima, ai metodi di allevamento o pesca, e ai processi di trasformazione.
Le cosiddette proteine vegetali, come quelle contenute nei legumi, vengono spesso identificate come equivalenti a quelle animali, ma si tratta di una semplificazione che può generare confusione. I legumi, per quanto apportino una quota proteica, rappresentano principalmente una fonte di carboidrati. La loro capacità di contribuire significativamente al fabbisogno proteico reale dipende da molti fattori: il tipo di legume, le condizioni di coltivazione, i processi di lavorazione, ma soprattutto il modo in cui vengono cucinati, masticati e digeriti. Tutto questo incide in maniera sostanziale sulla reale disponibilità e assorbibilità delle proteine.
Spesso si suggerisce l’abbinamento tra cereali e legumi per “completare” lo spettro amminoacidico, ma questa pratica può portare a un apporto significativo di carboidrati nel piatto. In chi necessita di mantenere un profilo glicemico stabile, tale combinazione può risultare poco funzionale, perché favorisce una produzione marcata di insulina, condizione che può ostacolare alcuni obiettivi nutrizionali, come la gestione del peso o il miglioramento di parametri metabolici.
Acido urico e apporto proteico: il ruolo delle purine
Quando si parla di acido urico alto, immediatamente si parla di escludere alcuni alimenti come diversi tipi di carne e pesce nella dieta. Si, l’acido urico in circolo nel sangue è un prodotto finale del metabolismo delle purine (composti che fanno parte degli acidi nucleici del DNA all’interno del nucleo cellulare). Sono presenti, quindi, sia nel nostro corpo che in diversi alimenti.
Le purine, ed in particolare le ipoxantine, non si trovano solo negli alimenti di origine animale ma anche in alcuni alimenti vegetali.
Un acido urico elevato nei valori del sangue può essere la conseguenza di un aumento di produzione, di una riduzione dell’escrezione a livello renale o di entrambe e i motivi di questo possono essere molteplici. Anche in questo caso, è fondamentale evitare generalizzazioni: l’impatto dipende da fattori individuali, come la funzionalità renale, lo stato infiammatorio, l’idratazione e certo anche la composizione globale della dieta.
A questo proposito è degno di nota che solo circa un 15% dell’acido urico che si forma giornalmente ha un’origine alimentare. Il restante è, appunto, l’obbligatorio prodotto finale di varie reazioni chimiche, tra cui il catabolismo degli acidi nucleici.
In caso di acido urico elevato quindi, non si tratta solo di fare delle generiche esclusioni perchè si rischierebbe di andare a determinare un deficit proteico causato dall’eliminazione o della forte restrizione di molte fonti proteiche contenenti anche purine.
Il Biologo Nutrizionista, in sinergia con il medico in caso di iperuricemia o gotta, valuta come distribuire correttamente l’apporto proteico, scegliendo fonti di qualità e modulando la frequenza d’uso degli alimenti più ricchi in purine, ed in particolare di ipoxantine, senza cadere in esclusioni inutili o controproducenti. Inoltre, ci sono molte altre indicazioni favorevoli in questa condizione da considerare ed altre da approfondire come per esempio l’utilizzo di caffè o tè, l’utilizzo di cotture adatte, la presenza di vitamina C nella dieta, la presenza di digiuni prolungati, la quantità e qualità dell’idratazione giornaliera, e così molto altro.
Non basta la categoria: serve attenzione alla fonte
Dire “uso proteine animali” o “uso proteine vegetali” non basta. Bisogna andare oltre le etichette e interrogarsi su che tipo di alimento stiamo scegliendo. Per esempio, una proteina di origine animale proveniente da un allevamento intensivo non ha lo stesso valore nutrizionale (né biologico né etico) di una da un sistema più controllato e naturale.
La prima vera discriminante, quindi, non è animale o vegetale, ma la qualità dell’alimento nella sua totalità, che include:
- Come è stato prodotto
- Con quali metodi è stato trasformato
- Quali altri nutrienti (o interferenti) porta con sé
Un piano nutrizionale costruito con attenzione non cerca solo di “fare numero”, ma di fornire al corpo gli strumenti giusti per funzionare in modo efficiente, supportando i processi metabolici in modo naturale.
I falsi miti sulle proteine: cosa non ti dicono
Le proteine sono circondate da una quantità sorprendente di informazioni errate o incomplete. Ecco perché è fondamentale fare chiarezza, liberando il campo dai falsi miti che condizionano negativamente le scelte alimentari di moltissime persone.
Le proteine affaticano i reni
Una delle credenze più diffuse è che “troppe proteine fanno male ai reni”. Questo è falso nei soggetti sani. Prima di tutto bisogna capire cos’è troppo e per quanto tempo. Studi scientifici confermano che un apporto proteico adeguato e contestualizzato non comporta rischi per la funzionalità renale in individui senza patologie pregresse. Il problema può sorgere solo in presenza di malattie renali già diagnosticate, e in quel caso è il medico a stabilire eventuali limiti.
La dieta moderna è già troppo ricca di proteine
Molti pensano che oggi si consumino troppe proteine, soprattutto a causa di diete iperproteiche. In realtà, i dati epidemiologici smentiscono questa visione. Per buona parte della popolazione, l’assunzione di proteine non raggiunge nemmeno i livelli ottimali per mantenere la massa magra e supportare i processi fisiologici. Spesso, si mangia tanto in termini di volume, ma poco in termini di qualità proteica.
Le proteine servono solo a chi fa palestra
Anche questa è una semplificazione errata. Le proteine sono essenziali in ogni fase della vita, non solo durante l’allenamento. Sono fondamentali per la crescita nei bambini, per il mantenimento nei giovani adulti, per la riparazione nei momenti di stress o malattia e per la prevenzione della sarcopenia negli anziani.
Pensare che servano solo “agli sportivi” riduce il loro ruolo a quello muscolare, dimenticando che sono coinvolte anche:
- nella sintesi enzimatica
- nella regolazione ormonale
- nella risposta immunitaria
- nella gestione dell’equilibrio glicemico
Accanto a questa visione distorta, è cresciuto anche il mercato di integratori proteici spesso di scarsissima qualità, promossi come scorciatoie efficaci. In realtà, l’integrazione deve sempre essere intelligente e precisa, valutata caso per caso dal Biologo Nutrizionista, tenendo conto della qualità delle materie prime, del contesto individuale e del reale fabbisogno.
Sradicare questi falsi miti è il primo passo per restituire alle proteine il loro ruolo naturale e fisiologico. In un piano nutrizionale su misura, costruito con un Biologo Nutrizionista, ogni scelta è orientata non al trend, ma alla funzione, rispettando i bisogni reali del corpo in ogni sua fase e condizione.
Calcolare il proprio fabbisogno proteico: perché non basta una formula standard
Una delle domande più frequenti quando si parla di proteine è: “Quante proteine dovrei assumere ogni giorno?”. Ed è qui che entra in gioco un altro errore molto comune: credere che basti applicare una semplice formula matematica per ottenere una risposta valida per tutti. In realtà, il calcolo del fabbisogno proteico è un processo che richiede personalizzazione e competenze specifiche.
Molti riferimenti generici, come il classico 0,8 g di proteine per kg di peso corporeo, rappresentano il minimo indispensabile per la sopravvivenza, e non il quantitativo ottimale per sostenere i processi metabolici, la massa muscolare e le attività quotidiane. Infatti, il fabbisogno proteico reale può variare anche oltre 1,6 g/kg, in base a molteplici fattori.
I parametri che influenzano il fabbisogno proteico
- Peso corporeo reale: non si calcola sulle “aspettative”, ma sulla situazione attuale della persona.
- Composizione corporea: una persona con più massa magra avrà un fabbisogno diverso rispetto a chi ha un’alta percentuale di massa grassa.
- Livello di attività fisica: chi è sedentario, chi cammina ogni giorno, chi fa sport o allenamento di forza ha esigenze molto diverse.
- Stato fisiologico: gravidanza, allattamento, età avanzata, recupero post-intervento o convalescenza sono condizioni che modificano le richieste dell’organismo.
- Obiettivo nutrizionale specifico: miglioramento della performance, supporto del tono muscolare, gestione dell’equilibrio glicemico, ricomposizione corporea.
Perché è utile il supporto di un Biologo Nutrizionista
Quando si parla di calcolo del fabbisogno proteico, è comune imbattersi in calcolatori automatici, tabelle generiche o formule precompilate che propongono un valore “standard” in base al peso corporeo. Ma questa visione semplificata non tiene conto della complessità dell’essere umano: ogni corpo è diverso, ogni storia personale è unica, e ogni risposta metabolica cambia nel tempo. È proprio in questo contesto che emerge l’importanza dell’intervento di un Biologo Nutrizionista.
A differenza di un approccio generico o automatizzato, il Biologo Nutrizionista valuta in modo critico e personalizzato numerosi parametri: peso corporeo reale, composizione corporea (massa magra e massa grassa), livello di attività fisica, eventuali condizioni cliniche, stato ormonale, fase della vita (infanzia, età adulta, menopausa, terza età) e soprattutto l’obiettivo specifico della persona (dimagrimento, mantenimento, aumento massa muscolare, miglioramento dell’energia quotidiana, ecc.).
Ma non è tutto. Una vera valutazione nutrizionale efficace va oltre il semplice dato numerico: richiede l’osservazione della risposta dell’organismo nel tempo. Un apporto proteico che “sulla carta” può sembrare corretto, nella pratica potrebbe non essere sufficiente o non ben distribuito. Il Biologo Nutrizionista è in grado di monitorare e modulare l’apporto di proteine in base all’evoluzione dello stato fisiologico della persona, adattando il piano nutrizionale a ogni cambiamento reale.
Strategia, non solo quantità
Inserire proteine in modo corretto non significa semplicemente “raggiungere un certo numero di grammi”. La vera efficacia sta in una scelta strategica delle fonti: valutare la qualità della materia prima, il profilo amminoacidico, la biodisponibilità e la sostenibilità dell’assunzione nel tempo. Anche la distribuzione delle proteine nella giornata ha un impatto: frazionarle correttamente nei pasti può migliorare l’efficienza metabolica e la sintesi proteica.
Inoltre, il Biologo Nutrizionista tiene conto delle interazioni tra nutrienti e della necessità di armonizzare le proteine con il resto della composizione del piatto. Il contesto alimentare in cui si inserisce una fonte proteica (presenza di carboidrati, fibre, grassi di qualità) ne modifica profondamente l’assorbimento e la risposta metabolica.
Non esiste un modello valido per tuttinsu
Affidarsi a formule “taglia unica” è un errore comune. Un algoritmo non può comprendere la storia di una persona, né interpretare i segnali del suo corpo. Solo un percorso guidato, costruito da un professionista, permette di inserire l’apporto proteico in un quadro realmente efficace, su misura, rispettoso dei bisogni fisiologici e degli obiettivi individuali.
Ecco perché il ruolo del Biologo Nutrizionista è centrale: non solo nel calcolo del fabbisogno proteico, ma nella costruzione di un piano nutrizionale intelligente, progressivo, coerente con la fisiologia umana, e capace di fare la differenza nel tempo.
Conclusione – Più qualità, meno approssimazione
In un’epoca in cui l’informazione alimentare è accessibile ma spesso approssimativa, fare chiarezza sul ruolo delle proteine diventa un passo fondamentale per educare a un’alimentazione consapevole, efficace e rispettosa dei reali bisogni dell’organismo.
Riepilogo dei concetti chiave
- Le proteine non sono una moda: sono molecole biologiche essenziali, fondamentali per la struttura e il funzionamento del corpo umano.
- Il fabbisogno proteico reale è spesso sottovalutato: molte persone, pur mangiando “di tutto un po’”, non raggiungono le quantità necessarie per garantire il corretto supporto metabolico e tissutale.
- Non tutte le proteine sono uguali: conta la qualità della materia prima, la biodisponibilità, il profilo amminoacidico e il modo in cui queste vengono integrate nella giornata alimentare.
- Non esistono formule universali: ogni persona ha un fabbisogno diverso, influenzato da età, attività, stato fisiologico, obiettivo. Per questo serve una valutazione professionale e personalizzata.
Un invito alla consapevolezza
L’obiettivo di questo approfondimento non è quello di fornire una “lista della spesa”, ma di stimolare una riflessione seria e concreta sul proprio modo di alimentarsi. Imparare a leggere i segnali del proprio corpo, a scegliere le fonti giuste e a dosarle con criterio può davvero fare la differenza nella qualità della vita.
Per questo motivo, il consiglio è sempre quello di affidarsi a un Biologo Nutrizionista: un professionista che lavora in modo integrato e su misura, ascoltando la storia individuale, valutando lo stato di salute e costruendo un piano nutrizionale adatto alla persona, non al trend del momento.
F.A.Q. - Domande frequenti sulle proteine
Il fabbisogno proteico non è uguale per tutti. I riferimenti ufficiali come i LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti) indicano un valore minimo di circa 0,8 g per kg di peso corporeo, ma si tratta di una soglia minima di sopravvivenza, non di ottimizzazione della funzione. In molti casi, soprattutto in condizioni specifiche (attività fisica, età avanzata, convalescenza), il fabbisogno può arrivare anche a 1,6 g/kg o oltre. È sempre il Biologo Nutrizionista a stabilire l’apporto corretto, valutando lo stato fisiologico, la composizione corporea e gli obiettivi della persona.
Le proteine animali si trovano in alimenti di origine animale come carne, pesce, uova, latticini. Sono generalmente considerate a più alto valore biologico perché contengono tutti gli amminoacidi essenziali in proporzioni ottimali. Le proteine vegetali, invece, provengono da legumi, cereali, frutta secca e derivati. Possono essere meno bilanciate sul piano aminoacidico, ma ben combinate e soprattutto di qualità, possono soddisfare il fabbisogno proteico. In questo caso però bisogna prestare molta attenzione a come non sbilanciare la propria nutrizione in favore dei carboidrati. Non esiste una fonte perfetta a priori: conta la qualità della materia prima e come viene integrata nel contesto del piano nutrizionale.
Il calcolo del fabbisogno proteico dipende da diversi fattori: peso corporeo reale, percentuale di massa magra, livello di attività fisica, stato ormonale e fisiologico, e soprattutto obiettivo nutrizionale. Non si tratta di una semplice formula applicabile a tutti, ma di una valutazione che richiede competenza professionale. Un Biologo Nutrizionista è in grado di valutare il contesto complessivo della persona e di costruire un piano proteico che non si limiti al “numero di grammi”, ma tenga conto della risposta dell’organismo nel tempo.
Questa è una delle affermazioni più diffuse, ma non corretta nei soggetti sani. L’idea che un apporto proteico “più alto del minimo” danneggi i reni non trova conferme nella letteratura scientifica attuale, a meno che non ci siano patologie renali preesistenti (e in quel caso sarà il medico a stabilire le restrizioni). Per il resto della popolazione, un’assunzione adeguata e contestualizzata non comporta rischi, anzi: supporta massa muscolare, sistema immunitario e funzioni metaboliche.
No. Non esistono alimenti “validi per tutti in ogni situazione”. La tolleranza, la funzionalità, la risposta metabolica e anche la qualità della fonte proteica variano da persona a persona. Un alimento proteico che per qualcuno è ideale, per altri può risultare poco efficace o non adatto. È proprio per questo che un piano nutrizionale personalizzato è indispensabile: per integrare le fonti proteiche giuste, nella quantità e nella combinazione più adatte al corpo e agli obiettivi di chi le assume.
Sì, le proteine, se inserite correttamente nei pasti, contribuiscono a modulare la risposta glicemica. Questo significa che possono aiutare a evitare picchi di glicemia e insulina, favorendo un rilascio energetico più costante e riducendo i meccanismi infiammatori. È una strategia fondamentale nei percorsi nutrizionali che mirano a ottimizzare la composizione corporea o a intervenire su condizioni metaboliche.
Non esiste un “momento perfetto” valido per tutti, ma la distribuzione delle proteine nei pasti principali (colazione, pranzo, cena) è generalmente più efficace rispetto all’assunzione concentrata in un solo momento. Questo approccio aiuta a sostenere la sintesi proteica, favorisce il mantenimento della massa muscolare e contribuisce a stabilizzare l’equilibrio glicemico. Anche in questo caso, la personalizzazione fa la differenza.
No. Le proteine variano per profilo aminoacidico, digeribilità e qualità biologica. Alcune contengono tutti gli amminoacidi essenziali in proporzioni ottimali, altre no. Alcune vengono assorbite facilmente, altre meno. Inoltre, la qualità della materia prima, il metodo di produzione e la lavorazione influenzano notevolmente la capacità del corpo di utilizzarle in modo efficace. Non si tratta solo di “grammi”, ma di funzionalità reale nell’organismo.
Le nostre sedi
Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti con l'aiuto di Nutrizionista Bio, se rispetti quello che ti dicono, garantisco ottimi risultati come nel mio caso. 11 kg.persi in30 giorni, fantastico, ora punto ad altri 5 kg.per i prossimi 30 giorni, vi farò sapere. La cosa più importante comunque è come mi sento dopo solo 30 giorni. Non russo più, non faccio più appnee, ma soprattutto ho tolto la pastiglia della pressione. Fan tas ti coooooo.Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Nutrizionista.Bio è un programma alimentare dove sei seguito dalla A alla Z. Io sono seguita dalla Dr.ssa Zilio che è veramente professionale, a modo, sempre positiva a dir poco fantastica! Lo staff è eccellente, cordiale, efficiente. Ogni dubbio o perplessità sono sempre presenti a sostenermi. Nonostante io mi sentissi a disagio per il mio peso in eccesso, loro non mi hanno mai fatto sentire sbagliata. Io sto seguendo questo percorso dall’estero quindi sono flessibili a fin che il cliente sia soddisfatto!(non ci sono più scuse) All’inizio può essere tosto perché ci sono delle regole. Ma vi posso garantire che è tutto questione di abitudine e nulla di assurdo. Ah dimenticavo, puoi mangiare gli alimenti che hai nel menu della giornata in quantità che desideri quindi non si fa la fame! Questa pianificazione alimentare mi ha svoltata la vita, in due fattori :fare la spesa, prepararmi i vari pranzi per il lavoro. Quindi la vita attualmente adesso è molto organizzata. Solitamente la colazione è una gioia per il palato e per gli occhi! È il pasto che preferisco, calcolando che non facevo praticamente mai colazione. Non volevo fare adesso questa recensione ma aspettare il mio traguardo finale. Ma poi ho pensato.. perché non farla adesso? Magari posso aiutare qualcuno a prendere coraggio e provare questo fantastico percorso. Perché, io stessa disperata e con la voglia di cambiare in meglio; mi sono messa a cercare nel web fin che non mi sono imbattuta su Nutrizionista.bio dove mi sono STUDIATA tutte le recensioni. Quindi, Detto ciò, Questa sono io dopo 5 mesi di percorso con 27 kg in meno.. ( nonostante qualche sgarro). La strada è ancora lunga. Quindi il mio giudizio può essere solo che positivo!Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Dopo molteplici esperienze, non proprio positive, ho conosciuto nutrizionista bio, dopo un anno ho perso quasi 20 kg, praticamente senza fare fatica, senza soffrire la fame, senza pesare il cibo, la mia forza fisica e resistenza è migliorata, così come è quasi scomparsa la mia decennale gastrite. Mi sento veramente meglio. Consigliatissimo è i risultati li vedi giorno per giorno. Un plauso allo Staff, bravi competenti e cordialissimi. Non si può pretendere di meglioTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ho seguito in modo abbastanza scrupolo il mio percorso e in soli due mesi ho raggiunto il mio obbiettivo, sono ritornato al peso forma di 10 anni fa, mi sento veramente bene e mangio con una nuova consapevolezza. Senza nessuna particolare fatica continuerò il mantenimento. Voglio scrivere qualche parola anche per tutto il personale che lavora come supporto di Team ai biologi, sempre presenti, sempre gentili, ti senti veramente a tuo agio in tutto il percorso. Grazie perché non avevo mai provato nulla di simile nei percorsi fatti in precedenza.Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Come ad ogni appuntamento a cui sono stata, il dottore che mi segue è molto gentile. Bravissimo nella spiegazione e non ci si sente giudicati!Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. E stata davvero una bella esperienza. Soprattutto una sfida con me stesso che la professionalità del personale mi ha aiutato a raggiungere. Grazie mille. Sono passato da 106kg a 93 in soli due mesi ,certo rinunciando a qualche cattiva abitudine abitudine , ma se si ascoltano i consigli del team i risultati si vedono e si sta subito meglio grazie ancoraTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Il percorso che ha seguito con voi mio marito gli ha permesso di raggiungere un equilibrio in termini di salute e di benessere psicofisico: oggi è molto meno affaticato, stanco e appesantito e in soli 4 mesi è riuscito a dimagrire 14,5 kg, mantenendo il peso anche in educazione alimentare. Aveva deciso di iniziare un anno fa perché il medico di base gli avevo trovato la pressione molto alta e doveva assolutamente perdere peso per una questione di salute. Nonostante lo spavento iniziale, oggi siamo felici perché la sua pressione si è normalizzata! Ha scelto questo percorso perché avevamo visto i risultati soddisfacenti che aveva ottenuto la compagna di nostro figlio e il fatto che sia una dieta qualitativa e non quantitativa… questo gli ha sicuramente permesso di vivere il percorso con molta serenità! Qui non ci sono integratori, non si devono pesare i cibi e ti insegnano un sano approccio all’alimentazione. Mio marito grazie al dimagrimento ha rispolverato vecchi abiti dall’armadio che ora gli stanno bene e ha ricevuto molti complimenti da chi non lo vedeva da un po’. Lo consiglia sicuramente a chi ha bisogno di acquisire un sano rapporto con il cibo, perché è davvero adatto a tutte le etàTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Oggi mi sento finalmente piena di energie, non vivo più con il senso di fame costante e ho ricominciato a guardarmi con piacere. Sono riuscita a perdere 9,3 kg in 2 mesi e oggi so di aver finalmente fatto pace con me stessa. La differenza con le diete provate in precedenza l’ho visto da subito: non si pesano gli alimenti, non si contano le calorie e non si patisce la fame. Per una persona come me che ha due lavori e poco tempo da passare ai fornelli, è stato fondamentale questo approccio. Ricette veloci, semplici e gustose che appagano il gusto e mi fanno dimagrire. Amo molto i dolci per cui trovare la panna tra i cibi proposti è stato bellissimo: ho adorato le colazioni con panna, fragole e noci oppure panna, mirtilli e cocco. Buonissime! Questa è la prova che dimagrire mangiando cibi gustosi è possibile. I risultati di questo percorso li ho visti fin dai primi giorni, ho perso anche 7-8 etti in un giorno e sentire le persone a me vicine e mio figlio dirmi “Si vede che hai perso peso” mi ha dato tanta motivazione. L’App è stata di grande aiuto perché è semplice da usare e ti permette di caricare le misure, consultare i menù e gestire la lista della spesa, così come ho trovato molto incoraggiante poter vedere le foto del prima e dopo, dove rispetto a quelle dell’inizio oggi vedo una differenza enorme. Ho consigliato e consiglio questo percorso a tutti coloro che vogliono perdere peso e tornare a volersi bene.